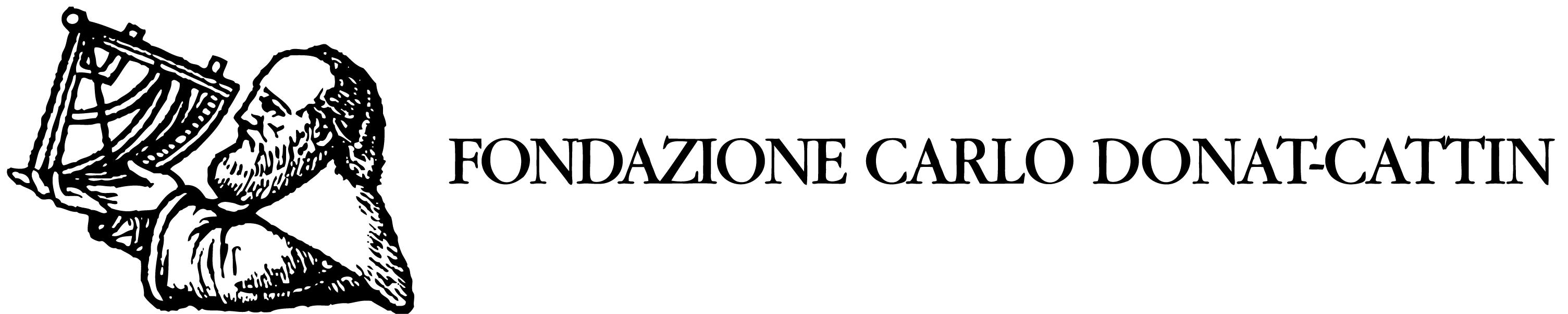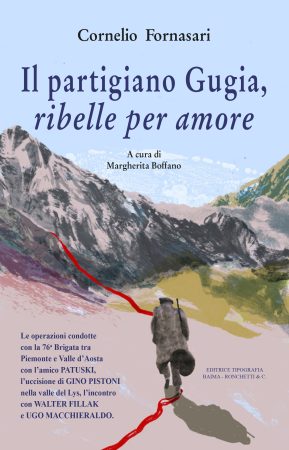Cornelio Fornasari, ribelle per amore.
La Resistenza canavesana nella testimonianza di “Gugia”

In occasione dell’ottantesimo anniversario della Resistenza, la Fondazione Carlo Donat-Cattin presenta per la prima volta al pubblico un documento finora inedito, che contribuisce ad arricchire il patrimonio memoriale della lotta partigiana, restituendone la complessità e la pluralità delle voci.
Con la pubblicazione del volume Il partigiano Gugia, ribelle per amore (Editrice Tipografia Baima – Ronchetti & C., 2025), viene finalmente resa accessibile una testimonianza diretta e vibrante, capace di restituire il senso umano, spirituale e civile dell’esperienza resistenziale vissuta da un giovane cattolico. Una scelta, la sua, maturata non per adesione ideologica, ma per una profonda esigenza etica e un senso di responsabilità coltivato nella solitudine della coscienza.
Partigiano nella 76ª Brigata Garibaldi con il nome di battaglia “Gugia”, Cornelio Fornasari offre, attraverso il suo racconto, una visione della Resistenza che travalica la dimensione militare per farsi riflessione morale, spirituale e politica: un cammino interiore segnato da interrogativi morali, tensioni ideali e fedeltà a una visione del mondo coerentemente perseguita.
A corredo dell’uscita del volume, pubblichiamo la presentazione di Gianfranco Morgando, già direttore e attuale membro del Comitato scientifico della Fondazione, che accompagna il lettore alla scoperta del valore civile e storico di questa preziosa testimonianza, invitando a coglierne, oltre l’evento, il lascito morale.
Presentazione
a cura di Gianfranco Morgando
Le memorie di Cornelio Fornasari – il partigiano “Gugia” della 76ª Brigata Garibaldi – costituiscono un contributo di grande importanza per la ricostruzione della storia della Resistenza canavesana e gettano una luce inattesa sulla complessità del fenomeno resistenziale: sulla sua pluralità, sulle motivazioni e sulle idee che si sono confrontate nei lunghi mesi della lotta di Liberazione.
Un testo prezioso, destinato a occupare un posto d’onore nella memorialistica partigiana della zona di Ivrea, che integra pubblicazioni già note – cito soltanto il bel libro di Saverio Tutino, La ragazza scalza. Racconti della Resistenza, edito da Einaudi – facendo emergere, accanto ai fatti d’arme veri e propri, il “clima” che si respirava nelle bande: le solidarietà e le amicizie nate tra persone di orientamenti politici e culturali diversi, il dibattito sul senso della lotta armata, sulle strategie militari e sulle prospettive future.
In particolare, il libro offre un contributo di grande rilievo per approfondire un fenomeno ancora poco indagato, nonostante numerose ricerche, anche recenti: quello delle dimensioni e delle caratteristiche della partecipazione cattolica alla Resistenza.
Su questo tema ha scritto di recente Giorgio Vecchio, ricostruendo la presenza dei cattolici nelle Resistenze dei vari Paesi europei, ma mancano ancora studi in grado di approfondire gli aspetti quantitativi di tale partecipazione. Le memorie di Cornelio Fornasari non risolvono il problema, nemmeno per l’area specifica di Ivrea, ma evidenziano chiaramente che non si trattò di un fenomeno marginale e limitato a esperienze individuali, bensì di una presenza numericamente significativa, capace di esprimere una visione originale della lotta armata contro il nazifascismo.
Se vogliamo individuare i temi caratterizzanti di questa specificità, credo che si possano riassumere in tre punti: le motivazioni, le idee sull’organizzazione militare, il rapporto tra fini e mezzi per raggiungerli.

Cornelio Fornasari, Cesano Maderno 27 febbraio 1920 – Valgrisenche 29 luglio 1973.
La vicenda di Gugia, dunque, come paradigma della complessa maturazione nella militanza giovanile cattolica di una opposizione al fascismo che nasce sul piano etico e culturale, e si trasforma soltanto più tardi in opposizione politica e, per molti, nella scelta resistenziale. La forte motivazione morale, prima ancora che politica, che guida le scelte dei giovani cattolici è all’origine della decisione di non dare vita, se non in casi eccezionali, a bande direttamente espressione del movimento cattolico o della nascente Democrazia cristiana, ma di inserirsi nelle formazioni esistenti, indipendentemente dalla loro connotazione politica. A Ivrea, la destinazione è quindi una brigata garibaldina, la 76ª, che abbiamo già ricordato, dove si ritrovano molti giovani cattolici. Proprio loro daranno un alto tributo di sangue alla prima azione bellica della brigata, con la morte di Gino Pistoni e con la sua testimonianza di fede in Cristo e nella Patria, scritta con il sangue sullo zaino. La descrizione dell’episodio fatta da Fornasari è uno dei capitoli più emozionanti del diario: Gino e i suoi amici decidono di soccorrere un nemico ferito, contro la volontà del loro comandante, ma, nella concitata fase di ripiegamento, le schegge di una granata feriscono mortalmente Pistoni, che muore dissanguato. Gugia lo vede cadere, ma non lo può soccorrere. Apprenderà più tardi della testimonianza lasciata con il sangue da “Ginas” e la proporrà nelle pagine dedicate al suo testamento spirituale.
In più capitoli delle memorie di Fornasari emerge una originale concezione della strategia militare, diversa da quella prevalente nei reparti. È la prima impressione al momento dell’arrivo al distaccamento partigiano a cui è assegnato: «Gugia si era subito reso conto che la fisionomia di quella formazione non era affatto di tipo militare», scrive, ma piuttosto era caratterizzata da una realtà composita dal punto di vista sociale, numericamente importante, ma non in grado di dare vita a una efficace strategia di lotta. Richiamo alcune frasi significative: «nei distaccamenti si cercava di escludere ogni forma di vita militare»; «la disciplina era ignorata, ritenuta una forma di oppressione»; «la principale funzione della formazione ribelle, nella mente dei suoi capi, era quella di formare politicamente e acquisire nuovi proseliti per il partito»; «l’attività militare doveva esistere soltanto come azione di supporto».
Le prime impressioni si strutturano, nelle riflessioni di Fornasari e dei suoi amici, e diventano una vera e propria teoria delle forme di lotta più opportune: no a una «guerra di posizione», impossibile da sostenere per lo scarso e inadeguato armamento; «molto più efficace la guerriglia», con pattuglie formate da pochi uomini decisi, pronti ad agire di sorpresa e ad allontanarsi dopo il colpo senza lasciare tracce. Una posizione che, poco per volta, verrà riconosciuta anche dai comandanti delle formazioni, che costituiranno, nel settembre del ’44, il “Distaccamento volante Ferruccio Nazionale”, in cui Gugia e il suo amico Patuski saranno incorporati. Le azioni di guerriglia del distaccamento sono descritte con viva partecipazione, fino al momento finale dell’attacco tedesco che lo disperde. Del resto, la prova che le teorie della guerriglia esercitavano un fascino particolare la troviamo nelle pagine che Saverio Tutino dedica a Gugia nel libro già citato, dove lo descrive come una sorta di campione solitario che progettava azioni coraggiose da compiere con pochi compagni: «non aveva mai fallito un colpo, e non era mai tornato con un compagno ferito», è il giudizio pieno di ammirazione.
La teoria della guerriglia non impedisce, però, di perseguire l’obiettivo di una maggior efficienza militare. Nelle sue memorie, Fornasari ricorda il favore con cui lui e i suoi compagni avevano accolto l’arrivo tra i partigiani di reparti dell’esercito che disertavano in modo organizzato, con i loro ufficiali e tutto l’armamento. Viene descritto con simpatia – una simpatia poco condivisa dall’opinione partigiana prevalente, nonostante il sostegno dei comandanti – l’arrivo al distaccamento di un gruppo di venti alpini guidati da due ufficiali: «era ora che arrivasse gente addestrata e abituata a usare le armi».
Resta il tema del rapporto tra fini e mezzi, che nelle memorie di Fornasari ha al centro la questione della giustizia partigiana. Fin dai primi giorni di arruolamento, Gugia assiste all’esecuzione sommaria di una spia fascista; il turbamento è grande e lo spinge a maturare una precisa posizione di dissenso nei confronti delle uccisioni senza processo, che non distinguono le situazioni in base alla gravità dei reati e non sono il frutto di una discussione aperta tra tutti gli uomini della formazione. Il libro riferisce molti episodi in cui lo scontro tra le indicazioni dei comandi e le valutazioni etiche di Gugia e dei suoi amici più stretti è molto forte. Tuttavia, le sue idee fanno breccia e, più di una volta, ottengono un consenso maggioritario tra i compagni: le condanne a morte vengono comminate soltanto nei casi di conclamata responsabilità per comportamenti efferati, mentre si cercano soluzioni alternative negli altri casi. Fornasari arriva addirittura a vagheggiare l’istituzione di campi di raccolta per i prigionieri, anche se ovviamente non se ne farà nulla.
L’opposizione alla giustizia sommaria non è un fatto isolato o individuale, ma finisce per assumere una valenza politica più ampia. Non è un caso che il tema sia oggetto di un lungo articolo pubblicato su «Per il domani», il foglio clandestino dei resistenti cattolici, stampato in pianura e diffuso a Ivrea e negli ambienti della Olivetti. Lo colgo come un segno del collegamento tra due realtà: quella della montagna e quella della città, di cui non si fa parola nelle memorie di Fornasari, anche se Ivrea costituisce lo sfondo di tante azioni ricordate nel libro, come l’attacco al distretto militare e molte operazioni di “commando”, che erano una specialità di Gugia. Il libro non ci dice nulla, ad esempio, sui rapporti tra i giovani cattolici delle bande e i dirigenti democristiani della Resistenza che stavano emergendo nel processo di organizzazione politica della lotta antifascista (Emilio Parato e Carlo Donat-Cattin erano entrati nel Cln di Ivrea in rappresentanza della Dc; all’Oratorio san Giuseppe e nella canonica di don Vesco si tenevano le prime riunioni clandestine per la costituzione del partito). Eppure, Saverio Tutino scrive: «Gugia era un cattolico e membro della Democrazia Cristiana». Forse qualcosa Gugia ci avrebbe detto se avesse completato il racconto; forse aveva avuto occasione di incontrare coloro che facevano da collegamento tra la montagna e le Sap della città (il dottor Pesando e Giorgio Cavallo, certamente); oppure, forse, il carattere prevalentemente morale della sua adesione alla Resistenza lo rendeva relativamente disattento nei confronti della caratterizzazione politica che veniva assumendo anche da parte cattolica. È un bel tema di riflessione, che può gettare ulteriore luce sulla questione cattolica nella Resistenza italiana.
Resta ancora da fare una considerazione. Accanto alla orgogliosa rivendicazione delle proprie idee e della propria autonomia di giudizio su aspetti importanti della vita partigiana, a cui ho accennato, Cornelio Fornasari si è distinto come un combattente a tutto tondo. Anche nei momenti più difficili, quando, sotto l’incalzare dell’offensiva nemica, i reparti si sbandavano e molti abbandonavano le formazioni, non ha mai avuto esitazioni o dubbi sulla sua scelta. Se non veniva coinvolto in azioni importanti, se ne lamentava temendo che venisse meno la fiducia dei compagni e dei comandanti nei suoi confronti. Non nascondeva il dissenso verso le decisioni che non condivideva, ma nutriva una profonda ammirazione per i suoi compagni e per la coerenza delle loro scelte. Parla molto di Walter Fillak, ne descrive l’arrivo al comando della 76ª e il suo ruolo decisivo nella riorganizzazione e nella rinnovata efficienza militare della formazione. Piange la sua cattura, di cui è testimone oculare, e la sua condanna, sottolineando la dignità con cui i prigionieri di Lace si comportano nell’attesa della morte. Sono belle pagine che rafforzano il valore della testimonianza di Cornelio Fornasari, il partigiano “Gugia”, nel farci comprendere meglio le gloriose vicende del contributo canavesano alla riconquista della libertà.
Gianfranco Morgando
Comitato scientifico Fondazione Carlo Donat-Cattin